
Il sapore del Lodigiano, una storia che si fa cultura
CIBO Apparecchiare la tavola e fare il pane, gesti di tutti i giorni che portano con sé una lunga tradizione
Apparecchiare la tavola, fare il pane in casa, preparare per ore gustosi piatti e dolci: tutti gesti quotidiani che a volte ci costano fatica, ma che portano con sé una storia che arriva da molto lontano.
Come scriveva nel 2004, in un suo saggio dedicato all’argomento, il docente universitario Massimo Montanari, il cibo è cultura perché ha trasformato il mondo, perché è il frutto della nostra identità e uno strumento per comunicarla. Un modo per scoprire e raccontare la società e la sua evoluzione in un percorso in cui certi sapori restano come un filo conduttore che attraversa i secoli.
Dietro ogni prodotto tipico c’è una storia che va oltre la cucina: è fatta di persone, di gesti tramandati, di intuizioni e legami profondi con la terra. In questi piccoli capolavori della tradizione gastronomica lodigiana si intrecciano artigianato, memoria, lavoro e cultura. Perché anche un biscotto, un formaggio o una mela possono diventare simboli, oggetti narranti, radici. In questa pagine ne raccontiamo alcuni: non solo per il gusto, ma per ciò che significano.
GLI AMARETTI - L’eco nostalgico delle partenze
C’è qualcosa di struggente negli amaretti di Sant’Angelo Lodigiano: un sapore che sa di partenze e ritorni, come quelli degli emigranti lodigiani che li portavano in valigia, omaggio per il Nuovo Mondo. Le suore di Madre Cabrini li ricevevano dall’Italia, simbolo di una patria che sapeva ancora di mandorla e zucchero. Anche il Papa e il Patriarca di Gerusalemme li hanno assaggiati: un piccolo dolce che viaggia lontano, come una preghiera sussurrata. Sono amaretti che non addolciscono soltanto il palato, ma la nostalgia.

IL BISCOTTO CODOGNO - La dolcezza della memoria
C’è un aroma che attraversa i secoli come una lettera d’amore non ancora letta. A Codogno lo si incontra nella pasticceria di via Roma, tra le scatole di latta decorate di medaglie e gloria. È l’aroma del biscotto di Cornali, inventato nel 1883 da Angelo, offelliere e visionario, che portava il suo biscotto alle fiere come un poeta in tournée. I suoi concittadini lo chiamavano “Bella testa”, fu suo figlio Mario ad aggiungere un tocco esotico all’ opera: il cocco. Da allora, questo biscotto è passato di generazione in generazione, come un verso di famiglia, tra le dita dei figli e dei nipoti. Un dolce che non solo si gusta, ma si ricorda.

IL GRANONE - La dignità del tempo
Il Granone è come quei vecchi maestri che non insegnano, ma mostrano. Un formaggio antico, citato fin dal 1500, che resiste alle scorciatoie della modernità con la forza del mestiere. Ha bisogno di mani sapienti, di latte eccellente, di tempo. È un grana che non si piega, non si adatta. In un’epoca che consuma, lui matura. È un pezzo d’Italia che si taglia con rispetto, come si sfoglia un libro antico, con le dita che tremano un po’.
LA MELA COTOGNA - Il frutto dolceamaro che non sa mentire
C’è un frutto che non cerca di piacere. Aspra, ruvida, dura: la mela cotogna si lascia amare solo da chi sa attendere. I greci la offrivano come pegno d’amore, ma non era un amore da zucchero: era il tipo di amore che profuma la biancheria della nonna, che si conserva nei cassetti e nei ricordi. È un frutto che sfida il tempo, e lo profuma. Sta tra l’Oriente e Lodi come un messaggio cifrato, che solo chi sa cuocerlo può comprendere.
IL VINO BANINO - Il silenzio della collina
La vigna non si improvvisa. È come la poesia: ha bisogno di cura, terra, stagioni. San Colombano lo sapeva, lui che veniva dall’Irlanda e insegnò a coltivare la vite come se fosse un atto di fede. È un vino di collina e di spiritualità, nato dalla bonifica viscontea e cresciuto in secoli di pazienza.
Tra il Cinquecento e il Seicento, la vite dominava l’economia locale come un canto gregoriano riempie una navata. Nel 1800 i critici lo paragonavano ai vini della Valtellina, ma forse è più giusto pensarlo come un vino che parla piano, come fanno i saggi.
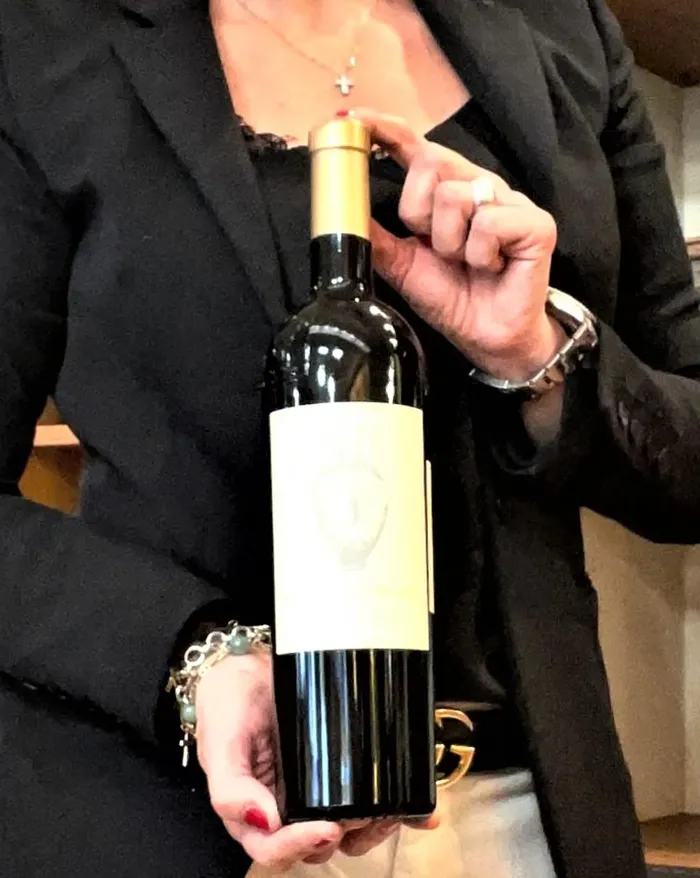
IL PANNERONE - L’anomalia felice e provocante
Il Pannerone non ha vie di mezzo. Come la panna da cui prende nome, o lo ami o lo rifiuti. Nessuna via diplomatica: è formaggio vivo, senza sale, senza maschere. È la provocazione del Lodigiano: un prodotto che non chiede compromessi, ma verità. Il suo sapore netto, grasso, pungente, ci ricorda che la cucina, come la letteratura, ha bisogno anche di voci fuori dal coro.

LA TORTIONATA - La torta più sincera amata da tutti
La tortionata è un romanzo familiare con la copertina di mandorle. La ricetta è dell’800, ma i suoi tratti sono medievali: bassa, secca, friabile. Nasce forse con un gioco di parole – “torta io nata” – o forse da un filo attorcigliato, come le vite che si incrociano in una piazza.
La sua consistenza è quella dei ricordi che non si lasciano affettare: si spezzano, si sbriciolano. Sta nei caffè del centro, nei bar storici, come una poesia lasciata in tasca: magari in pochi scelgono di prenderne una fetta per sé, ma tantissimi la comprano per regalarla, come un fiore donato che ha ancor più profumo.

LA CRESCENZA - La fragilità che si gonfia
Formaggio o metafora? La crescenza – o carsenza, come si dice nel Lodigiano – è pane e formaggio in uno stesso respiro. Si gonfia col caldo, si spacca, si lascia ferire come il pane che lievita. In un mondo che corre, lei resta tenera, disarmata, viva. Nata nei medesimi stampi della focaccia, racconta un’intimità antica tra cibo e casa, come una tavola contadina in cui nulla è diviso. È formaggio che non si lascia stagionare, come certe emozioni che vanno mangiate subito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA








